Per prepararvi adeguatamente all’arrivo della Buchmesse 2015 vi proponiamo un estratto da La Musa (Guanda), affascinante romanzo di Jonathan Galassi, editore e presidente di Farrar, Straus and Giroux, che si svolge dentro il mondo dell’editoria letteraria, americana e internazionale. Un capitolo ambientato proprio nei giorni intensi di Francoforte…
Capitolo VIII
La Fiera
La moderna Fiera del libro di Francoforte era un fenomeno del dopoguerra, uno strumento per facilitare la riammissione della Germania nel novero delle società civili occidentali. L’idea risaliva al Rinascimento, quando Francoforte era il più grande centro di scambi vicino a Magonza, la città dove Johannes Gutenberg e i suoi soci avevano inventato i caratteri mobili verso la metà del Quindicesimo secolo. Ripristinata nel 1949, la fiera era diventata il più importante raduno dell’editoria internazionale. Ogni anno, in ottobre, decine di migliaia di editori di tutto il mondo si agitavano come formiche tra gli squallidi padiglioni industriali ai margini del centro cittadino, correndo agli appuntamenti con i loro colleghi.
Ma nella moderna fiera di Francoforte non si vendevano libri, bensì autori, a un tanto al chilo. Gli editori si accaparravano il diritto di vendere le opere dei loro scrittori in altri paesi e altre lingue, spesso intascando una considerevole porzione dei guadagni (tra i più scandalosi c’erano i paternalistici francesi, che si beccavano il cinquanta per cento del ricavato). Finché gli agenti non si erano accorti delle potenzialità degli accordi internazionali, la situazione era rimasta selvaggia e confusa, anche se le parti in gioco osservavano scrupolosamente i riti feudali di lealtà. I responsabili dei diritti erano i più visibili sotto la campana di vetro di Francoforte, e la loro regina riconosciuta era Cora Blamesly della FSG, la Vergine di Ferro armata di mazza venuta dalle colline boscose della Carinzia, esperta nel brandire il suo accento posticcio dell’alta borghesia londinese – sovrapposto a un’inestirpabile base germanica – e le sue tecniche di vendita sadomasochistiche per strappare contratti scandalosi ai disperati «amici» europei.
Cora e i suoi simili non tiravano subito fuori i manoscritti più importanti, ma li «passavano» con un elaborato cerimoniale ai loro editor preferiti, esigendo che li leggessero da un giorno all’altro e sollecitando un’offerta preventiva, spesso gonfiata dalle aspettative e dalla tensione che permeavano l’atmosfera carnevalesca di Francoforte.
Gli europei erano disperati perché l’economia culturale del dopoguerra aveva imposto ai lettori italiani, tedeschi, giapponesi e brasiliani, e talvolta persino francesi, di leggere libri americani. E non solo i grandi autori commerciali, come Stephen King e Danielle Steel, ma anche gli Scrittori Seri. Prima c’erano stati i romanzieri ebrei, ansiosi e arroganti, seguiti da WASP meno interessanti e più vanitosi come Updike, Styron e Foxx; poi erano arrivati i novellini senza personalità, i ribelli impertinenti ma plausibili che Cora e i suoi omologhi gonfiavano come supernove per i quattro giorni della fiera, a volte anche per più di un libro, anno dopo anno. Nababbi dell’editoria europea come Jorge Vilas (Spagna), Norberto Beltraffio (Italia), Matthias Schönborn (Germania), e il più grande spendaccione di tutti, Danny van Gennep di Utrecht, giocavano a questo gioco da anni, ed erano indebitati con Cora per milioni. Quando Roger Straus, Lucy Morello o Rob Routman, l’affascinante caporedattore della Owl House, portavano un nuovo autore a Francoforte, tutti si agitavano – a volte, si diceva, leggendo solo qualche pagina (o addirittura nessuna) del manoscritto – perché spesso, o almeno abbastanza spesso, i loro libri «funzionavano», cioè vendevano bene in patria. Molti editori, però, facevano il passo più lungo della gamba, comprando titoli stranieri che sembravano destinati al trionfo ma che spesso, quando mesi dopo arrivavano le traduzioni commissionate, li spingevano a domandarsi, scuotendo la testa, come avessero fatto a scambiare un cane per un leone nel bar fumoso e semibuio dell’Hessischer Hof, che alle due e mezzo del mattino era ancora pieno di editor e responsabili dei diritti ammucchiati gli uni sopra gli altri, ubriachi e lascivi, sui divani sfondati.
Le bevute seriali in compagnia e le cene alcoliche langweilisch con i discorsi autocelebrativi degli editori ospitanti, seguite da ulteriori bevute notturne (e le convivenze in stile «lo stesso giorno, il prossimo anno» non erano cosa insolita), contribuivano all’incessante bonomia di Francoforte e alla frenesia degli acquisti. Come aveva detto a Homer un grande vecchio dell’editoria danese: «Veniamo a Francoforte tutti gli anni per vedere se siamo ancora vivi». Alcuni, purtroppo, non lo erano. I peggiori erano gli ex pezzi grossi che avevano avuto il cattivo gusto di ritornare, e ora si aggiravano per i padiglioni cavernosi attaccando bottone agli antichi colleghi nelle pause fra appuntamenti inesistenti. Erano spettri, apparizioni, e tutti lo sapevano, forse anche loro.
Francoforte non era un evento mondano: era frequentata da carnivori rapaci con una verniciatura di raffinatezza europea. Gli abiti eleganti, le feste, i sigari, i prezzi gonfiati di alberghi e ristoranti, il cibo deludente: faceva tutto parte dell’esperienza. La fiera era spossante, ripetitiva e deprimente, e chiunque contasse qualcosa nel mondo dell’editoria non se la sarebbe persa per nulla al mondo.
Homer era fatto per Francoforte. Da nessun’altra parte era così rilassato, pieno di saggezza bonaria e aneddoti spiritosi. Per anni si era rifiutato di mettere piede nella Germania del dopoguerra, ma era stato convinto da Brigitta Bohlenball, la vivace vedova di Friedrich Bohlenball, il magnate del latte svizzero che con una serie di acquisti oculati aveva usato il suo patrimonio e le sue convinzioni comuniste (uno svizzero comunista, rara avis!) per diventare uno dei più raffinati editori europei. Friedrich aveva fatto conoscere diversi scrittori e filosofi importanti prima di suicidarsi a quarant’anni, lasciando Brigitta e la piccola Friedchen con alcune centinaia di milioni di franchi, una villa vicino a Lugano e uno Schloss in Engadina, per non parlare della casa editrice più chic di Zurigo.
«Vieni, Homer. Ti divertirai tantissimo, te lo prometto» gli aveva mormorato Brigitta mentre pranzavano a La Caravelle, e aveva mantenuto la promessa, presentando la sua nuova preda americana agli editori europei più importanti, vale a dire più snob.
Se oggi parlare di editori snob può sembrare un ossimoro, è solo un indizio di quanto sia degenerato il concetto di classe nel dopoguerra. Gli aristocratici dell’editoria europea, i Gallimard, gli Einaudi, i Rowohlt, erano borghesi all’antica che avevano superato la guerra più o meno illesi, anche se talvolta con affiliazioni politiche non irreprensibili, come altri innumerevoli uomini d’affari europei. Non erano molto diversi, mutatis mutandis, da Homer, che per questo si sentiva a suo agio in mezzo a loro. E si sentiva davvero se stesso, in tutta la sua virile arroganza, nei padiglioni fumosi e freddi della fiera e nei bar e ristoranti fumosi e surriscaldati degli alberghi. L’appartenenza al club di Brigitta aveva da tempo placato i suoi scrupoli nei confronti dei crucchi, come continuava a chiamarli, e i saturnali di Francoforte erano diventati il culmine dell’anno editoriale di Homer e Sally.
Sembravano una coppia, e in effetti molti dei colleghi stranieri di Homer, alcuni dei quali avevano situazioni famigliari piuttosto simili, pensavano che fossero sposati. Paul ricordava una cena nella residenza cittadina di Homer, poco dopo la sua assunzione, insieme ad alcuni dei più noti autori stranieri della P&S, tra cui Marianne O’Loane, Piergiorgio Ponchielli e sua moglie, Anita Moreno. Norberto Beltraffio, uno dei più esuberanti colleghi europei di Homer, era entrato a passo deciso in salotto mentre Homer serviva il vino e spalancando le braccia aveva chiesto ai presenti: «Dov’è Sally?». Per fortuna in quel momento Iphigene non c’era.
Di regola, Homer e Sally passavano un lungo fine settimana alle terme sul lago di Costanza per riposarsi in vista della fiera, e poi si fermavano un paio di settimane a Londra o Parigi per riprendersi in grande stile. In tutto si facevano un mese di vacanza a spese dell’azienda, come sostenevano alcuni a New York.
Con gli anni molti erano arrivati a considerare Homer il decano degli editori letterari di Francoforte; Brigitta lo aveva incoronato «re della fiera». La sua partecipazione ai rituali, la piccola cena che organizzava ogni anno dopo la chiusura, per la quale alcuni illustri editori europei rimandavano la partenza, il suo fascino e il suo modo di vestire, che s’intonava all’ambiente e che lì sembrava meno esagerato e vistoso che a New York, perfino i suoi sigari cubani di contrabbando: tutto questo alimentava il prestigio di Homer nei padiglioni e nei bar di Francoforte. Lo stand della P&S, spartano come gli uffici newyorkesi, era adiacente a quello di un importante distributore internazionale, e veniva invaso da visitatori di ogni parte d’Europa, America Latina e Asia, venuti a baciare l’anello d’oro con sigillo sulla mano venata di Homer.
Oltre a quella che frequentavano Homer e Sally, accompagnati negli ultimi anni da Paul, c’erano altre Francoforti che non c’entravano niente con loro. I Grandi Editori (nel senso di commerciali e irrilevanti) come Random House, HarperCollins, Simon & Schuster e Hachette, si scambiavano contratti multimilionari, anche se gli agenti si tenevano sempre più stretti i diritti per l’estero e si aggiravano come iene fra padiglioni e stand, o addirittura, scimmiottando gli editori con un gesto scandaloso come quello del parvenu McTaggart, allestivano un proprio stand con tavolini eleganti e cataloghi voluminosi distribuiti da ragazzi discreti (che faccia tosta!). E poi c’era la Francoforte dell’editoria religiosa; la Francoforte delle pubblicazioni tecnico-scientifiche; la Francoforte degli editori di libri illustrati; la Francoforte dell’editoria universitaria; la Francoforte dei paesi in via di sviluppo. Per non parlare della Francoforte degli editori ospitanti, che non serviva solo per concludere accordi a quattr’occhi, ma apparteneva anche ad autori, critici, giornalisti – sembrava incredibile, ma in Germania libri e scrittori facevano ancora notizia – e dopo i primi due giorni anche ai lettori, che ciondolavano in giro come turisti ostacolando il passaggio nei corridoi.
Tutte quelle fiere, e altre ancora, si svolgevano contemporaneamente negli stessi spazi, cavernosi come enormi megastore. I loro frequentatori sciamavano nella zona fieristica spostandosi su lunghi tappeti scorrevoli, o con i treni dei pendolari in partenza dalla bella stazione antica, che evocava un’Europa prebellica; poi tornavano negli atri pericolosamente affollati degli alberghi dove restavano a bere fino alle ore piccole, e il giorno dopo si aggiravano rauchi e intontiti dall’alcol e dalla mancanza di sonno, dopo una notte passata a lamentarsi, mentire, adulare, fumare e bere, ingozzarsi e raccontare balle e bere e scopare e divertirsi un mondo.
Gli editori letterari, tuttavia, consideravano Francoforte una loro proprietà esclusiva. Erano loro a stabilire il tono, a pubblicare gli Autori Importanti, e a volte partecipavano imprudentemente a ricevimenti e conferenze, anche se quelli un po’ scafati imparavano in fretta che si trattava di inutili intralci agli affari. Gli editori letterari erano i Signori della Cultura, i parassiti principali seduti in cima a quel letamaio brulicante. Il loro senso di importanza era evidente quando si aggiravano per i padiglioni, ondeggiando come se fossero a bordo di un transatlantico, cosa che in un certo senso era vera, anche se non lo sapevano: una lenta ed enorme nave dei folli destinata fatalmente a schiantarsi contro il grande iceberg digitale. Partecipavano a ricevimenti privati gemütlich dove la marmaglia non era invitata (gli inviti esclusivi erano un rituale della fiera, spediti con mesi d’anticipo e in certi casi addirittura ambiti). Si scrutavano attentamente ma con discrezione mentre ricamavano sulle loro ultime scoperte, che potevano anche essere, ma che in genere non erano, quei contributi fondamentali alla Letteratura Mondiale per cui loro volevano farli passare. I professionisti fra quei ladri gentiluomini si intendevano benissimo fra loro: dove finiva l’amicizia e prevaleva il commercio; dove il commercio si teneva in disparte e la lealtà faceva valere i propri diritti. Homer era molto generoso con le informazioni, buone e cattive, ed era esperto nello spargere quelle dicerie che rappresentavano la linfa vitale di Francoforte: McTaggart stava trasferendo Hummock da Gallimard ad Actes Sud; Hummock aveva mollato McTaggart per la Ninfo; la Ninfo stava vendendo in blocco la sua agenzia alla William Morris.
Homer stringeva accordi speciali per mantenere certi autori all’interno della cerchia ristretta – il cénacle, o cartello, come lo chiamava qualcuno – di case editrici indipendenti, informalmente diretta da lui e dai suoi complici. Era un antiquato mercato delle vacche, certo, ma spesso si rivelava salutare per gli autori, perché col tempo, se avevano stoffa (e alcuni di loro l’avevano davvero, altrimenti il castello di carte sarebbe crollato molto tempo prima), acquisivano fama internazionale, espandendo il loro pubblico insieme ai profitti dell’editore.
Diversi autori di Homer – più di quelli di ogni altro editore americano tranne FSG, la sua eterna spina nel fianco – avevano ricevuto Quello Grosso, il Pezzo da Novanta, il massimo riconoscimento della Letteratura Mondiale, il premio più ambito che lui inseguiva costantemente: il Nobel per la Letteratura, conferito dalla riservatissima Accademia di Svezia. Negli Stati Uniti il Nobel aveva meno peso commerciale che altrove, ma il suo prestigio era tuttora irraggiungibile. Negli ultimi anni Homer aveva intascato Nobel come altri collezionavano orologi. Sette degli ultimi dodici premi per la letteratura erano andati ad autori P&S, creando parecchio scontento fra gli altri. Homer si era vantato pubblicamente di essere in confidenza con il re di Svezia, il cui compito principale sembrava quello di distribuire le medaglie del Nobel.
Il vincitore veniva tradizionalmente annunciato il giovedì della fiera all’una del pomeriggio, durante la frenetica ora di pranzo. I pezzi grossi erano troppo signorili per starsene lì ad aspettare l’annuncio; tuttavia i loro tirapiedi sapevano dove trovarli nel momento fatidico. Quell’anno, per la prima volta da decenni, Homer non era andato a Francoforte; aveva un intervento per la sostituzione dell’anca che non poteva più rimandare, e Sally era rimasta a casa per dare una mano. Così Paul era andato da solo, a calcare con prudenza le orme voluminose del capo nell’immutabile routine di incontri e ricevimenti, sperando di smentire l’immagine di zotico malvestito che la cricca di Homer doveva essersi fatta di lui.
Nel 2010, come già succedeva da qualche anno, era circolata la voce che Ida Perkins fosse nella lista dei candidati al Nobel. Nessuno sapeva quanto fosse attendibile quell’ipotesi. Di rado i presunti favoriti – nessuno sapeva neppure se davvero esistesse una rosa di finalisti – ottenevano la vittoria, e se uno scrittore o una scrittrice venivano menzionati ogni anno, alla fine diventavano merce stantia, con meno speranze di un outsider di ricevere il massimo premio, anche se la merce stantia poteva miracolosamente tornare fresca da un giorno all’altro e vincere, come era successo più di una volta. Quell’anno Ida, che a ottantaquattro anni era entrata nel territorio dell’Ora o Mai Più, era di nuovo considerata una potenziale vincitrice: era ora che toccasse a un americano, a una donna, a un poeta: perché non tutte e tre le cose insieme?
«Adesso devi dirmelo, Paul» piagnucolò Maria Mariasdottir, che lo aveva intrappolato nel bar del Frankfurter Hof, una serie di sale spaziose arredate con divani e poltrone abbondanti anche se mai sufficienti al pianterreno dell’albergo preferito di Hitler, più grande e trascurato dell’esclusivo Hessischer Hof dall’altra parte della città. Di sera il Frankfurter Hof diventava un carnaio ancora più sudato e fumoso dell’Hessischer Hof, talmente affollato di cacciatori di teste letterari che era impossibile muoversi. Paul lo paragonava al terzo girone dell’Inferno.
«Chi è questa Ida Perkins?» continuava a chiedere Maria.
Maria era una giovane e industriosa editrice di Reykjavík, con un bel fisico e gli occhi da cerbiatta, che spesso chiedeva consiglio ai colleghi di altri paesi perché non poteva permettersi di pagare qualcuno per leggere i libri che le venivano inviati.
«Ida Perkins è per la poesia americana quello che Proust è per il romanzo francese. Sul serio.» Paul si accorse con disgusto di avere parlato in francofortese, un gergo commerciale che odiava e che tuttavia aveva imparato a usare con disinvoltura, persino riferendosi a Ida; benché non fosse una «sua» autrice, si sentiva obbligato a nominarla in ogni occasione. Era quasi mezzanotte, molto dopo la sua solita ora X, ma la folla aveva appena cominciato a addensarsi come una salsa rancida. Aveva bevuto troppo e doveva tornare al suo albergo a due stelle, nel quartiere a luci rosse vicino all’Hauptbahnhof.
«Sì, ma è davvero brava? Cioè davvero, davvero, davvero brava? Devo saperlo.»
«Sì, Maria, Ida è davvero, davvero, davvero brava, la migliore. Te lo garantisco, e non è neanche una nostra autrice, ahimè.»
«Ne sei proprio sicuro? Perché tradurla sarà difficile e costoso…»
«Maria, non conosco il tuo mercato. So solo che Ida Perkins è la poetessa americana dei nostri tempi. E la sua opera è destinata a durare. Chiedilo a Matthias Schönborn, se non mi credi. Pubblicherà l’anno prossimo la raccolta di tutte le sue poesie. Chiedilo a Beltraffio. O a Jean-Mari Groddeck. Loro ne sono convinti.» Spesso il fatto che certi editori prestigiosi avessero un autore in catalogo produceva un effetto irrazionale sui loro colleghi stranieri.
«Sì, ma è davvero, davvero brava?»
«Davvero, davvero, davvero brava, Maria. Davvero.» Sperava di non aver farfugliato, ma non poteva escluderlo.
«Non sono convinta» disse Maria.
Paul alzò le braccia e le schioccò un imbarazzante bacio sulla fronte (gli europei erano bravissimi a dare baci finti, senza contatto fra labbra e pelle, ma gli americani non lo erano altrettanto). Almeno Maria voleva davvero, davvero sapere se valeva la pena di tradurre Ida. La verità era che ciò che andava forte a New York spesso arrivava morto a Reykjavík, e viceversa: quella era la terribile verità e forse anche la salvezza dell’editoria internazionale. A volte Paul desiderava che esistesse una pillola del giorno dopo per Francoforte; ma un accordo era un accordo, anche se era stato concluso quando una delle parti era ubriaca fradicia, o magari entrambe.
Così, il mattino dopo, quando prese il posto di Homer al tavolo di Matthias Schönborn nel padiglione tedesco per l’annuale discussione – o per meglio dire, conferenza – sui premiati e vendutissimi autori mitteleuropei di Matthias, Paul era guardingo. Se ci fosse stato Homer, lui e Matthias, che si piacevano da matti, avrebbero trascorso mezz’ora a raccontarsi barzellette sconce e denigrare i loro più stretti collaboratori, contenti come maiali nel letame; ma Paul avrebbe dovuto accontentarsi di un autentico incontro d’affari. Sapeva per esperienza che pochi, se non nessuno, degli scrittori proposti da Matthias avrebbero sfondato in America, proprio come sotto sotto sapeva che Matthias, uno dei più astuti tra i vanagloriosi editori internazionali, assai ammirato per l’esuberanza e l’incessante promozione dei suoi autori – una specie di versione europea aggiornata di Homer – non era realmente interessato agli scrittori pubblicati da lui e Homer. Certo, Matthias si sarebbe lamentato perché Eric Nielsen, diventato ormai un’importante figura internazionale, era pubblicato da Friedchen Bohlenball, anche se lui non aveva mostrato il minimo interesse quando Paul, qualche anno prima, gli aveva parlato con entusiasmo della sua scoperta. La verità era che a Matthias non interessava quello che faceva Paul, così come a Paul non interessavano gli emigrati russi e iraniani che sbarcavano il lunario guidando il taxi a Berlino. Eppure ogni anno discutevano animatamente – «Lui mente a me e io mento a lui» diceva Homer –, si scambiavano gli inviti alle feste e si comportavano come i migliori amici di tutta Francoforte, ciascuno cercando di individuare nel fiume di parole dell’altro una perla rarissima: lo scrittore eccezionale che avrebbe fatto la fortuna di entrambi. La capacità di ascoltare era secondo Homer la dote del vero «cane da tartufi» dell’editoria. Molti, purtroppo, ascoltavano solo se stessi.
Tuttavia nel corso degli anni Matthias e Homer, e adesso anche Paul, avevano condiviso certi importanti autori di fama internazionale, fra cui i Tre Assi di Homer. E Matthias, lui stesso un rispettato scrittore d’avanguardia (Homer aveva pubblicato alcuni dei suoi cupi e astrusi romanzi brevi, prima di lasciar perdere), era anche l’editore tedesco di Ida ed era al corrente della passione di Paul per lei e le sue opere. Inoltre, da astuto insider qual era, sembrava sempre in possesso di informazioni riservate sulle decisioni di Stoccolma, e quell’anno non faceva eccezione.
«È possibile» disse a Paul. «Ci sono altre correnti in moto, ma è possibile.»
Paul non sapeva cosa pensare di quella specie di oracolo. Poteva solo fare quello che facevano tutti gli altri: aspettare.
All’una, intorno allo stand, c’era un silenzio assordante. Dopo un’attesa tormentosa, si sparse la voce che l’olandese Hendrijk David era riuscito a strappare la maggioranza dei voti e ad aggiudicarsi il premio. Si diceva che ci sperasse da tempo, e che ogni anno, la mattina del giorno fatidico, si sedesse compiaciuto accanto al telefono.
La voce, tuttavia, risultò errata. Il premio lo aveva vinto Dries van Meegeren, un altro saggista olandese molto più oscuro, e subito si scatenò una zuffa indecorosa per l’acquisizione dei suoi diritti, ancora in gran parte disponibili. Editori di quasi tutto il mondo, che prima di allora non avevano mai sentito nominare van Meegeren, sciamarono nel padiglione olandese solitamente vuoto, ansiosi di comprarsi un premio Nobel. Lo stand di De Bezige Bij («L’ape industriosa»), la fortunata casa editrice di van Meegeren, sembrava lo sportello di una compagnia aerea dopo la cancellazione di un volo. (David, invece, non si sarebbe mai ripreso, e sarebbe morto nella più profonda amarezza un paio di anni dopo.)
Ad ogni modo, il premio non era andato a Ida. Questo significava, cercò di consolarsi Paul, che poteva ancora vincere.
Telefonò a Homer non appena aprì l’ufficio di New York.
«Ma ci credi che ha vinto Dries?» ridacchiò, stordito dall’incredulità. Van Meegeren inseguiva il Nobel da secoli: faceva reading in tutta la Scandinavia, scriveva articoli sulle opere dei membri dell’Accademia Svedese, si era addirittura messo con una svedese che si diceva fosse in confidenza con il segretario dell’Accademia.
«Sono anni che quell’imbroglione bacia il culo agli svedesi» rispose Homer. «Speravo che vincesse Les, o Adam. Voglio un poker, lo sai.»
«Lo avrai, Homer. Ogni cosa a suo tempo. Tutti ti mandano i loro auguri» disse Paul, riferendogli i saluti di molti suoi complici di vecchia data.
«Divertiti e non combinare guai. Ci vediamo lunedì.»
«No, non lunedì. Dopo la fiera vado a Venezia da Ida Perkins, ricordi?»
«Giusto.» Paul lo sentì schiarirsi la gola dall’altra parte dell’oceano. «Bene, dalle una pacca sul culo da parte mia, e dille che l’aspettiamo sempre a braccia aperte. Tienimi aggiornato!»
«Contaci… almeno per le ultime due cose» rispose Paul, e riagganciò. La fiera durava ancora due giorni, ma lui non vedeva l’ora che finisse. Andò agli appuntamenti come un sonnambulo e si sforzò di farsi vedere a qualche ricevimento, cercando di sentirsi entusiasta per la cena di venerdì della P&S, dove avrebbe sostituito Homer. Non riusciva a non pensare che, come lui, gli amici di Homer avrebbero partecipato senza convinzione, in mancanza dell’Impavido Capo in cui vedere rispecchiata la loro ben collaudata immagine di Grandi della Cultura, o marescialli di Francia, come qualcuno li chiamava. La presunzione era onnipresente, Paul lo sapeva, ma nel mercato delle vacche di Francoforte c’era un’untuosa acrimonia che trovava disgustosa, soprattutto quando toccava anche lui. Non aveva niente a che vedere con la poesia di Ida Perkins o i romanzi di Ted Jonas, scritti in solitudine, con fatica e angoscia. L’idea di Ida, Eric Nielsen o Pepita in mezzo a quei mercanti di parole ben vestiti e ben pasciuti che si comportavano come se possedessero la pelle dei loro scrittori gli dava la nausea.
Il venerdì sera si alzò in piedi nel suo completo dozzinale davanti al lungo tavolo del ristorante semideserto dell’albergo, dove la cricca di Homer – Brigitta, Norberto, Matthias, Beatriz, Jorge e Lalli, Héloise, Gianni, Teresa – aspettava, ne era sicuro, di vederlo commettere un errore. Tentò di imitare uno dei brindisi improvvisati e audaci di Homer, ma di solito i suoi tentativi di fare lo spiritoso in pubblico risultavano forzati. Eppure sembrava che andasse tutto bene, finché non commise lo sbaglio di nominare gli e-book.
«Diamine, presto vi gusterete Padraic, Thor, Pepita e Dmitrij sui vostri reader, proprio come noi!» esclamò con allegria simulata, visto che non ne aveva mai aperto uno.
Fu come se avesse scoreggiato a tavola, o evocato l’Olocausto. Brigitta e Matthias strabuzzarono gli occhi e tirarono in dentro le guance come spettri usciti dai Disastridella guerra di Goya, immaginando l’orda digitale che avanzava da Ovest come l’ultimo ceppo dell’influenza americana. Grazie a Dio, quando li avesse raggiunti, loro sarebbero stati troppo vecchi per preoccuparsene.
Paul si rattrappì sulla sedia. Cosa avrebbero detto Homer e Sally quando avessero saputo, perché sicuramente lo avrebbero saputo, che si era dimostrato una volta per tutte inadatto a quel mondo protetto e antiquato?
Non vedeva l’ora di respirare l’aria fetida della sua adorata Venezia, dove si rifugiava spesso dopo la tediosissima serra della fiera. Innaffiò il resto della braciola di vitello con troppo Rotwein sciropposo, accompagnò gli ultimi ospiti fuori dal funereo ristorante e prese il treno di mezzanotte con un certo anticipo. Arrivò a Venezia all’alba del giorno seguente, teso per l’emozione dopo una notte insonne.
Si concesse di prendere una lancia sul Canal Grande, sbalordito come sempre dalla stranezza di Venezia. I palazzi chiusi poggiavano direttamente sull’acqua oleosa color loden (cosa li sosteneva?). Il cielo andava dal perlescente all’azzurro Bellini. Paul provava ondate di euforia e repulsione, incanto e resistenza. Venezia era un incubo allucinatorio, l’ambiente più artificiale del mondo: una Disneyland per adulti. Odorava di sesso e della sua compagna putrescente, la morte. Thomas Mann aveva catturato alla perfezione la sua atmosfera imbellettata e febbrile.
Cosa ci faceva lì Ida Perkins, l’incarnazione della rubiconda esuberanza e dell’ottimismo americani? Quello era un posto per nascondersi, per dileguarsi, non per afferrare la vita per il bavero come aveva sempre fatto Ida. Era stata forse contagiata dallo scoramento del vecchio A.O.? Oppure aveva trovato una nuova vita con Leonello Moro? Ida era ancora la stessa?
Paul passò la mattinata vagando, colpito ancora una volta dalla bellezza apparentemente casuale degli spazi pubblici italiani, assestatasi nel tempo in un’irregolarità disinvolta. In Italia si era sempre sentito più leggero, libero da aspettative, le sue e quelle degli altri; lì poteva muoversi a suo piacimento, senza ostacoli e inosservato, come a volte si sentiva anche a New York, camminando anonimo tra la folla di mezzogiorno. Pranzò sotto il sole autunnale in una trattoria di Campo Santo Stefano e provò a resuscitare il suo italiano addormentato. Rilesse il libro veneziano di Ida, Aria di Giudecca, che meglio di ogni altro sapeva raccontare il decadimento e l’incandescenza di quel luogo («città di ebrei santi / di vicoli e di amanti / di macchie e di incanti»). Poi, mentre beveva il caffè , si mise a sfogliare le trascrizioni dei taccuini di A.O.



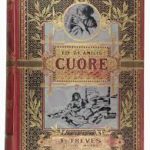

Comments by primaedizione